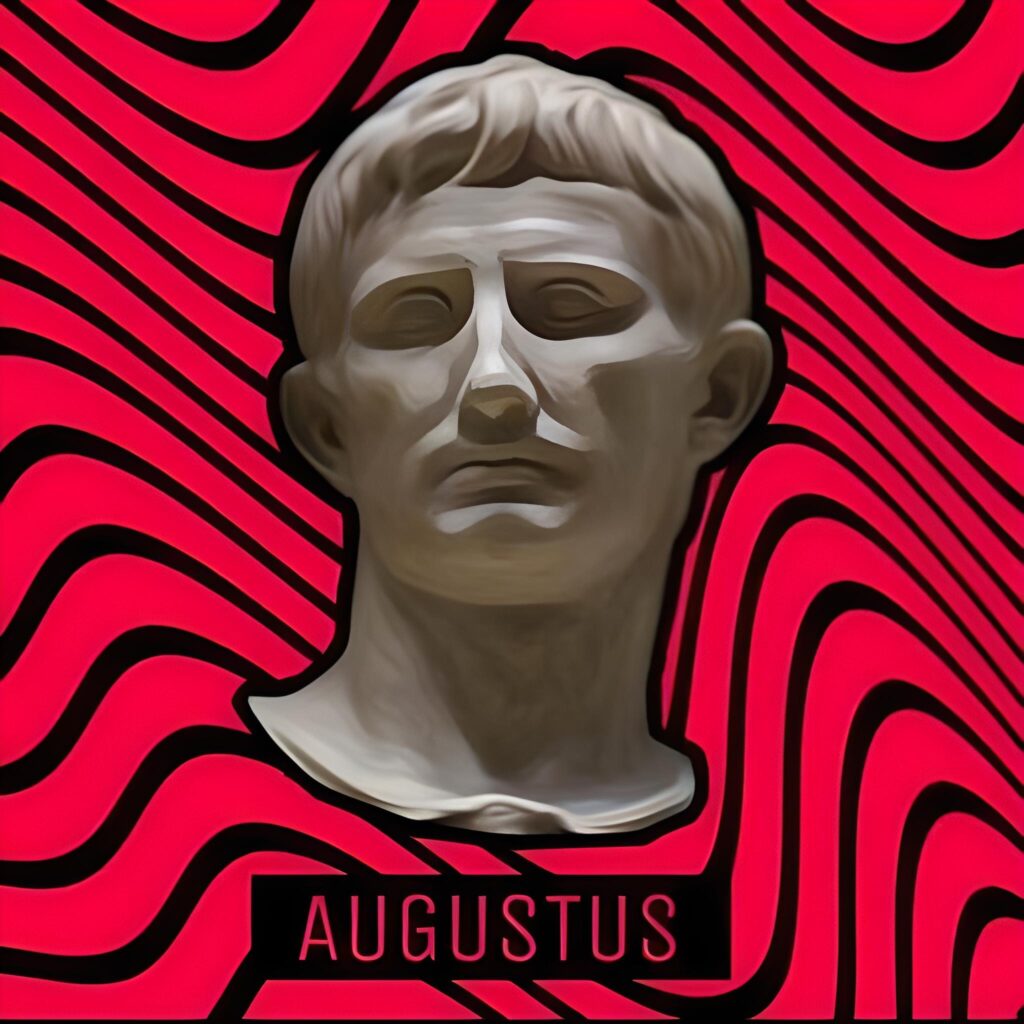“Ma il giorno che rinunciasse, che non insistesse più, che trasformasse l’ansia in dolore cocente, quel giorno che cosa gli resterebbe? Il vuoto, la solitudine, la prospettiva di un futuro sempre più squallido e morto. Dio, aiutami!”
E così, in una Milano degli anni ‘60 grigia e malinconica, Antonio Dorigo, un ordinario borghese di
quarant’anni, laureato in architettura, s’invaghisce de “La Laide”, una giovane prostituta di diciannove anni, cinica e spregiudicata.
Forse sarebbe più corretto dire che egli s’invaghisce, non della Laide, bensì dell’idea della Laide, di ciò che ella rappresenta.
A questo punto, per me, appare quasi ironico il titolo del romanzo, “Un amore”: è possibile innamorarsi di un’idea? di ciò che questa rappresenta per noi? è amore lasciarsi asfissiare dal sentimento o ammalarsi per quest’ultimo, come fosse un’infezione o una qualche malattia?
Durante il corso della lettura infatti, si è ingabbiati dentro la testa di Antonio, annebbiata dai suoi pensieri,
dalle sue ossessioni, gelosie, e alla fine del romanzo, ci si sente soffocati e ci si domanda cosa sia realmente l’amore, che significato abbia e che cosa veramente rappresenti per l’uomo, se uno scorcio di vita o una malattia mortale.
Per Antonio, il protagonista, l’amore è il φάρμακον : fa cessare il senso di solitudine che avvinghia l’uomo e, al contempo, lo avvelena, si ammala di un malattia che egli stesso si è procurato. Ma la malattia, il tormento che Laide gli provoca non è nulla in confronto alla solitudine e al vuoto in cui teme di sprofondare; per evitare che ciò avvenga Antonio non fa che costruire un’idea, l’idea della persona che egli ama, o meglio, che crede di amare. Partorisce l’idea della Laide, con tutto ciò che lei gli può regalare, giovinezza, sesso, divertimento.
Ma dietro di lei, un po’ più in là, c’è la solitudine, l’ansia spasmodica, una pungolante noia.
Per questo Dorigo preferisce patire la cocente gelosia, le bugie di Laide, l’amore non ricambiato, perchè è
tristemente consapevole che senza l’ansia e al contempo l’eccitazione che Laide gli procura, si condannerebbe a una vita ordinaria e mediocre.
Sembra quasi che il protagonista sia innamorato di un fantasma, di un’illusione che aleggia e che vaga nella sua testa per tormentarlo.
A tal proposito rimane proprio il dilemma della Laide: se lei è viva, e come esiste.
Lo è, indubbiamente, ma la sua idealizzazione, il suo fantasma, viene meno solo nel momento in cui Antonio, rapportandosi con lei, sfodera tutta la sua misoginia e sprezzo nei suoi confronti, in quanto prostituta.
E’ interessante come nel protagonista vivano due impulsi vivi e in contrasto tra loro: “mettere in riga” la
Laide, educarla, con la violenza se necessario, assestandole uno schiaffo in pieno viso, renderla una donna del focolare ed estirpare ogni traccia da prostituta; dall’altra però, Antonio desidera ardentemente lo spirito da femme fatale della Laide, la libertà e la spregiudicatezza che ella sprigiona, che è cio che lo ha fatto ossessionare così tanto.
Nel protagonista impera dunque un conflitto tra amore e odio nei confronti della Laide.
A gettare luce su questo, è l’incontro con la Piera, amica di Laide e anch’ella prostituta; alla fine del romanzo, spiega ad Antonio che lui, pur credendosi innamorato della Laide, la reputasse in realtà una disgrazia e una povera prostituta. In tal senso, dal punto di vista della Piera, Antonio non è che l’emblema di un “rispettabile” borghesia, piena di pregiudizi, di orgoglio, una borghesia che pur apprezzando una prostituta nel letto, la schifa durante il giorno. Ritengo, per questo, estremamente pungente l’attacco della Piera che afferma “ Ci considerate di razza inferiore, voi borghesi, anche se di noi avete bisogno, anche quando ci strisciare ai piedi” e che rivela, con grande acutezza, un’ipocrisia che ancora oggi pervade la nostra società.